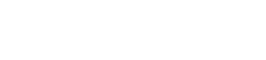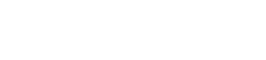|
TARANTELLA LUCIANA: i versi sono di
Libero
Bovio, uno dei quattro grandi poeti dell’Epoca d’oro della Canzone
napoletana, la musica è di Enrico Cannio; fu scritta nel 1913.
Protagonista della canzone è una splendida fanciulla di Santa Lucia, una
luciana, appunto, bella e spavalda, alla quale un ardito giovanotto
chiede con decisione di voler ballare una tarantella in un’atmosfera
evocativa di motivi e momenti nostalgici di un recente passato.
 Figlio di Giovanni Bovio, filosofo e uomo politico, che dalla nativa Trani (Bari) si era trasferito a Napoli per tenere all’Università
“Federico II” un corso libero di filosofia, il nostro Libero si
affermerà come uno dei massimi esponenti della poesia napoletana. Figlio di Giovanni Bovio, filosofo e uomo politico, che dalla nativa Trani (Bari) si era trasferito a Napoli per tenere all’Università
“Federico II” un corso libero di filosofia, il nostro Libero si
affermerà come uno dei massimi esponenti della poesia napoletana.
Alla morte del padre abbandonò gli studi superiori per scarso profitto,
riuscendo a trovare un posto di scrivano presso il Museo nazionale.
Iniziò a scrivere da drammaturgo, dando al teatro dialettale alcune sue
opere: “Casa antica”, “Mala nova”, “Vincenzella”, con alterno successo,
ma non sarà questa la strada cui dovrà la sua fama.
Il suo vero esordio artistico avvenne nel campo della canzone,
nonostante la mamma avesse sempre tentato di scoraggiare il ragazzo in
certi suoi malcelati propositi canzonettistici, suonandogli spesso
musica classica.
In un suo libro di ricordi Libero Bovio confesserà: “Mamma mi
convinceva, invece, della superiorità di Gambardella e Di Capua su
Beethoven”.
Artista poliedrico ed innovatore della canzone napoletana, Bovio è da
annoverare tra i pionieri di un nuovo genere canzonettistico:
la
“Canzone di giacca”, un tipo di canzone ad alto contenuto drammatico,
avente come protagonista gente del popolo, per la cui esecuzione e
presentazione meglio si addiceva “la giacca”, in luogo del frac che
aveva caratterizzato l’abbigliamento del cantante fino ad allora.
Fioriva a Napoli da alcuni anni la cosiddetta “Sceneggiata”, una sorta
di spettacolo melodrammatico, ispirato ad una canzone di successo e
costituito da una serie di canzoni, in cui la prosa fa solo da
approssimativo filo conduttore. Bene: non vi fu canzone di Bovio da cui
non scaturisse anche una sceneggiata.
Della sua vasta produzione ricordiamo:
-
“Canta per me!”,
-
“ 'A canzone ‘e
Napule”,
-
“Sona chitarra” e
“Tu ca nun
chiagne”, musicate da Ernesto De Curtis, lo stesso compositore di “Torna
a Surriento”, i cui versi furono scritti dal fratello Gian Battista De Curtis;
-
“Reginella”,
“O mare canta” e “Silenzio cantatore”, musicate da Gaetano
Lama;
-
“Surdate” e
“Chiove”, musicate da Evemero Nardella, un altro artista di
origini pugliesi, essendo nato a Foggia, dopo P.M. Costa e L. Bovio, che
ha dato lustro alla Canzone Napoletana, diplomandosi al Conservatorio
“S. Pietro a Maiella”;
-
“ ’A serenata ‘e Pulicenella”, musicata da
Enrico Cannio;
-
“Guapparia", musicata da
Rodolfo Falvo;
-
“Brinneso”
e “L’Addio”, musicate da Nicola Valente;
-
“ ’O paese d’o sole”, musicata da
Vincenzo D’Annibale;
-
“Lacreme napulitane” e
“Pupatella”, musicate da Francesco Buongiovanni;
-
“Zappatore”, musicata da
Ferdinando Albano;
-
“Passione”, musicata da
Nicola Valente ed Ernesto Tagliaferro.
In lingua, per esigenze varie, Bovio ha scritto più di una canzone, a
dimostrazione del fatto che la cosiddetta “Canzone all’italiana” è
partita anche da Napoli per merito dei vari Capurro, Bovio, E.A.Mario,
Gill.
Ricordiamo di Bovio:
-
“Amor di Pastorello”, musicata da
Emanuele Nutile e che io, da bambino,
ascoltavo in casa dalla intonatissima e dolcissima voce della mia cara
mamma; mi sembra ancora di sentire “La campana fa ndon-ndin-dò ed il
gallo chicchirichì…”, cominciava proprio così!
-
“Cara piccina", musicata da
Gaetano Lama;
-
“Signorinella”, celebre canzone musicata da
Nicola Valente.
A proposito delle canzoni in lingua Bovio tenne a chiarire il suo
giudizio in merito che è questo: “Gesù parlava in dialetto, Dante
scriveva in dialetto, il Padreterno, in cielo, parla in dialetto”.
Gioviale ed arguto, scanzonato ed ironico, di aforismi simili il poeta
ne scrisse centinaia, raccogliendoli poi in un volume dal titolo “Don
Liberato si spassa”, unitamente ai tanti episodi di una sterminata
aneddotica che lui stesso si ingegnava di alimentare.
Poco prima di chiudere gli occhi per sempre aveva pregato sua moglie
Maria di porgergli penna e carta e aveva scritto dei versi intitolati
“Addio a Maria”:
“Maria, salutammella
Napule pe me.
Dille che è stata
‘a passione mia,
dille che l’aggio amata quanto a tte!”.
Quei versi furono scolpiti sulla sua tomba.
Più tardi Giuseppe Marotta, l’indimenticabile autore de
“L’oro di
Napoli”, scrisse. “Napoli è veramente orfana di Libero Bovio; la poesia
dialettale l’ha perso come un albero perde le sue radici”.
Di Enrico Cannio dirò che fu un ottimo direttore d’orchestra, oltre che
un apprezzato musicista e compositore; era, infatti, diplomato al
Conservatorio “San Pietro a Maiella”. Oltre a “Tarantella Luciana”, su
versi dello stesso. L. Bovio ha scritto la musica della già citata “ ’A
serenata ’e Pulicenella” in cui Bovio, dopo “Guapparia”, ancora una
volta ridicolizza ed umilia la figura del “guappo” fino a farlo
diventare un Pulcinella nelle mani della donna amata; è anche del
Maestro Cannio “Rusella ‘e maggio”, su versi di Arturo Trusiano.
Compose molte altre canzoni, quasi tutte a tempo di marcia, genere in
cui era diventato uno specialista. La più famosa di questo repertorio è
la celebre " ’O surdato ‘nnammurato” del 1915, su versi di Aniello Califano:
divenne l’inno ufficioso dei bersaglieri, ma rimane una stupenda canzone
d’amore. |