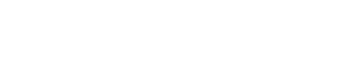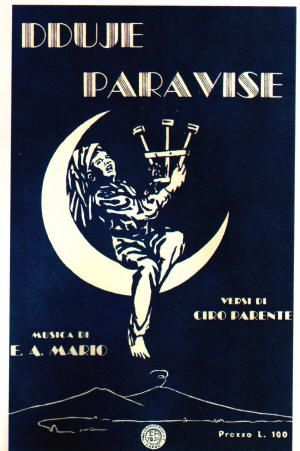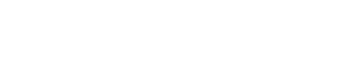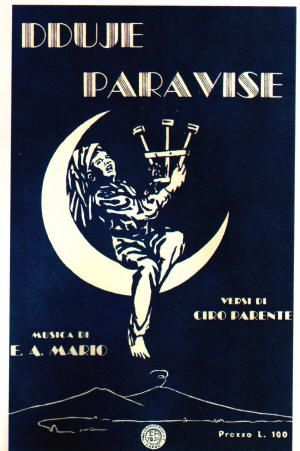|
DDUIE PARAVISE
è del 1928, versi di Ciro Parente, musica di E.A. Mario.
Questa canzone è frutto della fervida fantasia di un giovane
giornalista-poeta, funzionario di banca, che, con i suoi versi, aveva
teorizzato l’esistenza di due Paradisi, uno in cielo, l’altro in terra,
giungendo alla conclusione che per i napoletani il vero Paradiso si
trova in terra e si chiama Napoli.
Aveva esagerato Ciro Parente? Forse
sì, se la Chiesa ritenne blasfemi quei versi e se, nonostante l’immenso
successo ottenuto dalla canzone nel giro di pochi giorni, molti parroci
nelle prediche domenicali si erano scagliati contro l’autore di quei
versi. E meno male che lo stesso E.A. Mario aveva provveduto a cambiare
l’ultimo verso del testo, che nella stesura originale così recitava: “E
n’atu Paraviso nun ce sta”, modificandolo in un più accettabile “ ’O
Paraviso nuosto è chillu llà”.
Divenne famoso da un giorno all’altro Ciro Parente, che scrisse altre
canzoni, tra cui vanno ricordate “Pe chi se canta?”, musicata da
Salvatore Baldi e la gradevolissima “ ’A ricetta ‘e Napule”, musicata dal
valente musicista M° Pasquale Frustaci, ma le vetta del suo primo
successo non saranno più raggiunte.
Dopo S. Di Giacomo, E. Murolo, L. Bovio, ecco
E.A. Mario a completare il
quadro dei “Quattro Grandi” dell’Epoca d’oro della Canzone napoletana.
 Figlio di un barbiere con attività nella vecchia Napoli,
Giovanni Ermete
Gaeta (questo il vero nome di E.A. Mario) imparò da ragazzino a
strimpellare il mandolino nella bottega paterna. Impiegatosi più tardi
alle Poste di Napoli, cominciò a scrivere i suoi primi versi all’età di vent’anni, affidandoli al Maestro
Raffaello Segré che si era recato
nell’ufficio postale per spedire un vaglia, pregandolo di musicarglieli.
Nacque così “Cara mammà”, una canzone diventata celebre nel giro di
pochi giorni. Siamo nel 1904. Figlio di un barbiere con attività nella vecchia Napoli,
Giovanni Ermete
Gaeta (questo il vero nome di E.A. Mario) imparò da ragazzino a
strimpellare il mandolino nella bottega paterna. Impiegatosi più tardi
alle Poste di Napoli, cominciò a scrivere i suoi primi versi all’età di vent’anni, affidandoli al Maestro
Raffaello Segré che si era recato
nell’ufficio postale per spedire un vaglia, pregandolo di musicarglieli.
Nacque così “Cara mammà”, una canzone diventata celebre nel giro di
pochi giorni. Siamo nel 1904.
Inebriato dall’inatteso successo il giovane impiegato-poeta volle
trovarsi un nome d’arte. Dal suo secondo nome Ermete venne fuori la E.,
dal nome del direttore del quotidiano di Genova “Il Lavoro”, Alessandro Sacheri, col quale collaborava, prese la
A. e dal nome di Mario Rapisardi, personaggio mazziniano di cui era grande stimatore, prese
Mario, nome che, secondo alcuni studiosi, potrebbe anche essere
riferibile a Maria Clarvy, poetessa slava e giornalista che firmava i
suoi lavori con lo pseudonimo di Mario su un giornale letterario “Il
ventesimo”, al quale collaborava anche il nostro giovane Gaeta.
L’anno successivo, ancora con la musica di Raffaello Segré. G.E. Gaeta
scrisse “A Margellina”; nel 1908 fu la volta di “Ammore ‘e femmena”,
musicata da Evemero Nardella. Seguì nel 1910 “Amore guaglione”, musicata
da Vincenzo Ricciardi.
Dal 1911 in poi E.A. Mario divenne musicista dei suoi stessi versi,
merito, come egli stesso raccontava, di quel mandolino che aveva
imparato a suonare “nella bottega di papà”.
Va subito detto che E.A. Mario scrisse e musicò oltre duemila canzoni,
alternandole ad una vasta attività giornalistica, teatrale e di erudito,
frutto di una cultura che gli veniva da approfonditi studi giovanili
autodidattici.
Della sua sterminata produzione vanno ricordate:
-
“Comme
se canta a Napule”,
-
“Funtana all’ombra”,
-
“Maggio si’ tu”,
-
“Io, na
chitarra e ‘a luna”,
-
“Buongiorno a Maria”,
-
“Napule mio”,
-
la celebre “Santa Lucia luntana”, canzone con la quale, da attento osservatore,
colse e sottolineò il triste fenomeno dell’esodo dei nostri emigranti
nell’immediato primo dopoguerra,
-
“Canzone
appassionata” e
-
“Presentimento”.
-
Su versi di E. Murolo musicò
“Tammurriata all’antica”,
-
su versi di S. Di
Giacomo, "Mierolo affurtunato", una sorta di "Passero solitario",
-
su versi di
Alfredo Melina musicò "Core furastiero",
-
su versi di
Gigi Pisano "Primma, siconda e terza",
-
scrisse i versi
di "Napule è 'na canzone" musicata da Alberto De Cristofaro.
-
Nel 1944
E. A. Mario, su versi del consuocero Eduardo Nicolardi, musicò la
famosissima "Tammuriata nera" (...E' nato nu criaturo niro
niro...), in cui Nicolardi con garbato, intelligente ed arguto
umorismo tratta un tema delicato e scabroso quale quello dei bimbi neri
nati da giovani donne napoletane, che si erano accompagnate a soldati di
colore angloamericani della Quinta Armata alleata sbarcata a Napoli
sbarcata a Napoli agli ordini del generale Clark.
Fra le
"Canzoni di giacca" più famose scritte da E. A. Mario vanno
ricordate:
-
"Cinematografo", di cui firmò solo i versi, ricorrendo addirittura
ad un altro pseudonimo: A. Silla; la musica è di Raffaele
Prisco, collaboratore di E. A. Mario;
-
"Canzone 'mbriaca",
su versi del grande S. Di Giacomo;
-
" 'O festino" e "
'A legge", entrambe su versi di Pacifico Vento, lo stesso poeta autore
dei versi della celebre "Torna"; dalla canzone " 'A legge" fu tratta una
sceneggiata che all'epoca riscosse notevole successo di pubblico e di
critica.
Riguardevole e di
grande successo fu anche la produzione in lingua del nostro E. A. Mario.
Ricordiamo la famosissima
-
"Balocchi e
profumi",
-
"Ladra",
-
"Vipera",
-
"Le rose
rosse": queste ultime due, tipiche canzoni da "Café chantant",
fecero la fortuna di Anna Fougez (nome d'arte di Anna Pappalardo),
la bellissima "chanteuse" (sciantosa per i napoletani) del
varietà che dominò letteralmente le scene in Italia e all'estero a
cavallo delle due guerre mondiali.
Allo scoppio
della grande guerra E. A. Mario fu trasferito in un ufficio postale di
Bergamo. Fu allora che il Nostro compose
-
"Canzone di
trincea" e per diffonderla, dopo averla fatta stampare a sue spese
in migliaia di copie, spesso raggiungeva le prime linee e la insegnava
ai soldati.
-
Nella notte del
23 giugno del 1918 nacque "La leggenda del Piave", che
oltre ad assurgere all'epoca quasi ad inno nazionale, dopo poche
settimane divenne popolare anche sulle linee del fronte, suscitando uno
straordinario effetto psicologico nei nostri soldati e commuovendo, alla
fine, tutti gli italiani.
Nel 1946
E. A. Mario musicò la sua ultima canzone " 'O vascio", su versi
di Mario Giuseppe Cardarola. Fu una malattia a fargli prendere la
decisione di lasciare ogni attività pubblica.
Nel giugno 1961 si spense "Il figlio del barbiere", per il quale
Napoli aveva coniato un altro appellativo, definendolo "Il Signor
Tutto della Canzone napoletana" quando, prima della grande guerra,
volendo essere indipendente dagli editori, aveva fondato una propria
casa editrice chiamandola, manco a dirlo, E. A. Mario.
Con E. A. Mario,
ultimo grande esponente di un periodo aureo e fecondo ha termine quella
che è stata definita
"L'epoca d'oro
della Canzone napoletana"
Dal 1930 in poi la canzone napoletana subisce un lento, inesorabile ed
inarrestabile declino, pur registrandosi di tanto in tanto qualche
isolato successo, come " 'Na sera 'e maggio" di Gigi Pisano
e Giuseppe Cioffi del 1938 e "Munasterio 'e Santa
Chiara" di Michele Galdieri ed Alberto Barberis del
1945.
Vari motivi concorsero a determinare questa fase di decadenza della
Canzone napoletana, primo fra tutti la graduale scomparsa dei grandi
poeti ai quali si sostituirono i parolieri ed i verseggiatori, che, pur
apprezzabili per la loro produzione canzonettistica, mai raggiungeranno
le vette e la purezza della poesia di chi li aveva preceduti.
Altro fattore non trascurabile è il fiorire di nuove forme e tendenze
musicali; la canzone napoletana è assediata da mille mode, italiane e
straniere, fino alla contaminazione dei nuovi ritmi d'oltre oceano
portati a Napoli dai soldati alleati angloamericani durante la seconda
guerra mondiale.
In questa pur mutata e tormentata atmosfera musicale, a Napoli,
ovviamente, si continuava a scrivere canzoni.
L'Italia, e in particolar modo Napoli, che aveva subito ben 144
bombardamenti, si leccavano le ferite inferte dalla guerra: lutti,
distruzioni, miseria!
In questo quadro desolante venne fuori la fervida fantasia dei
napoletani, che inventarono mille mestieri per sopravvivere, come
quello, ad esempio, dei suonatori ambulanti, che vide, a volte, anche
intere famiglie portarsi nelle piazze dei paesini dell'entroterra
campano e cantare canzoni napoletane accompagnandosi, nei casi più
disperati, anche con un solo malridotto strumento a corde, chitarra,
mandolino o violino che fosse, nella intima e viva speranza che il buon
cuore dei passanti offrisse qualche lira che consentisse loro di
sbarcare il lunario.
La prossima
canzone della mia Antologia tratta proprio questo fenomeno:
" 'O viulino".
|